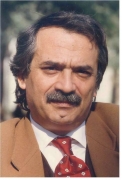
[01/03/2010] News
Firenze futura: città metropolitana rinnovabile e sostenibile
FIRENZE. Nel 2003, in occasione della presentazione dell'ultimo Piano strutturale di Amsterdam, è uscito un libro che riporta il commento di un giovane urbanista italiano che, nel 1949, così commentava la sua breve esperienza di "osservatore" dei processi di pianificazione attuati in Olanda: «Amsterdam è frutto di una particolare situazione geografica, espressione di una particolare mentalità collettiva sostanzialmente pratica, aliena dalla retorica ed incline all'ordine formale ed alla disciplina spaziale, una vera e propria lezione di modestia che dovrebbe essere a lungo meditata soprattutto dagli amministratori delle nostre città».
Si potrebbe esprimere lo stesso giudizio di questo giovane urbanista, parlando oggi di Firenze? E, soprattutto, chi era questo giovane urbanista che, nel 1949, aveva 34 anni?
Era Giovanni Astengo, divenuto negli anni successivi il "padre nobile" dell'Urbanistica italiana, al quale va il merito di aver intuito per primo la distinzione più efficace tra "città metropolitana" e "metropoli", proprio nel momento in cui, sulla base del Piano generale di espansione della città di Amsterdam (redatto nel 1935), Astengo invocava la nascita, anche in Italia, di Piani strutturali capaci di dare alla città contemporanea europea una "forma" finita e compatta.
«Città metropolitana è un sistema composto da una città principale e da altri centri minori ad essa strettamente connessi da rapporti economici, sociali e culturali intensi e quotidiani. Essa si caratterizza per una continuità urbana estesa del costruito e per un elevato grado di integrazione ed interdipendenza delle attività economiche, del sistema dei trasporti e dei servizi essenziali».
Questa era la definizione, più volte citata da Astengo, che permetteva di distinguerla dalla Metropoli, dove invece l'espansione quantitativa dell'urbanizzazione ed il consumo urbano dei suoli liberi rompeva ogni connessione culturale, ogni connettività paesistico-ambientale, ogni relazione di identità sociale, in una vorace e vertiginosa conquista di ogni spazio utile al mercato per l'urbanizazione.
Astengo provava verso la Metropoli la stessa preoccupazione di Lewis Mumford che, nel 1956 all'Università di Princeton, nel suo celebre discorso "The Natural History of Urbanization", avvertiva l'opinione pubblica mondiale che i rischi più minacciosi per gli equilibri ecologici planetari, sarebbero derivati dalla proliferazione delle Metropoli nei paesi occidentali e delle Megalopoli nei paesi del terzo e Quarto Mondo.
Oggi, dopo la pubblicazione del Rapporto Stern sui cambiamenti climatici a scala globale, sappiamo che tutti questi ammonimenti di quasi sessanta anni fa , erano drammaticamente veri e inoppugnabili.
Nonostante tutto ciò, ancora oggi la distinzione tra Metropoli e città metropolitana è vaga e confusa, anche se si è finalmente compresa la lezione di Giovanni Astengo sulla necessità di introdurre negli strumenti di governo e gestione del territorio, i Piani strutturali ed i Piani strategici, per tracciare un " confine" di sostenibilità ecologica e sociale allo sviluppo della città contemporanea.
In altre parole, città metropolitana non è Metropoli, pianificare e progettare la città metropolitana è il miglior modo per impedire la diffusione della Metropoli. Ricordando il dibattito caro al movimento ambientalista degli anni 80 sui "limiti della città", oggi abbiamo compreso che tale limite non è un "vincolo"e che esso non è soltanto verificabile da una valutazione della "dimensione quantitativa" dell'estensione della città, quanto dai meccanismi di relazione, di connessione e di connettività che essa conserva ed implementa nel corso delle trasformazioni del suo sviluppo economico e della sua organizzazione e morfologia territoriale.
Una città metropolitana è un sistema complesso di biodiversità culturale, sociale, economica e paesaggistica, tenute insieme da precise connessioni, reti, legami di identità e da cicli rinnovabili di risorse locali.
Dunque, per definire sostenibile lo sviluppo di una città metropolitana non abbiamo bisogno soltanto di misurarne la carrying capacity e l'impronta ecologica, ma abbiamo bisogno di valutarne la qualità delle sue connessioni, l'efficacia delle sue reti ecologiche, l'identità sociale e culturale dei luoghi urbani, l'utilità sociale dei suoi spazi pubblici.
Anche per questi motivi, gli strumenti valutativi insiti nella strumentazione delle Agende 21 non hanno funzionato come misuratori del benessere e della qualità urbana e appaiono ormai come strumenti incapaci a misurare la sostenibilità dello sviluppo della città contemporanea.
Le Agende 21, generate dal compromesso raggiunto intorno al tavolo mondiale di Rio de Janeiro (1992) da circa 156 governi di Stato, sono servite a introdurre importanti concetti di "valutazione" nell'uso delle risorse e delle materie prime da parte delle città moderne, osservate come se esse fossero assimilabili ad un grande "sistema produttivo", dal momento che, fino ad allora, la città contemporanea era stata denominata "città fordista".
Tuttavia, quel modello di città volgeva ormai al declino e la Terza rivoluzione industriale aveva creato le condizioni per una nuova rivoluzione del "modello occidentale" di città: I grandi processi di globalizzazione economica e finanziaria avevano introdotto un nuovo modello di città contemporanea, quello della Città Globale all'interno di un sistema mondiale di Reti di Città in competizione feroce tra di loro per affermare prima, un'egemonia culturale e, successivamente, un'egemonia economica e finanziaria.
(1-continua)
