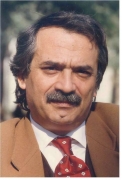
[08/03/2010] News
Firenze può essere oggi definita Città Globale?
FIRENZE. La mia risposta, insieme a quella di molti urbanisti italiani, è No. Non lo è perché ha rinunciato persino ad essere una città metropolitana di tipo policentrico, utilizzando i residui ambienti rurali peri-urbani e i numerosi spazi aperti naturali delle sue aree pedecollinari e i vuoti urbani ricavati dalle numerose "dismissioni" industriali e commerciali, come "aree di transizione" tra l'espansione urbana novecentesca della città comunale con la nascente conurbazione lineare della Piana lungo l'asse Prato-Pistoia.
La rinuncia a questo obiettivo ha cause "dolose", dal momento che circa 20anni fa una legge nazionale, la 142/1990, sia pur imprecisa e ambigua, aveva liberato l'iniziativa di circa 14 aree strategiche, intorno ai principali capoluoghi regionali italiani, verso un'iniziativa politico-istituzionale che sapesse distinguere tra il ruolo della Provincia e quello di città metropolitana.
La rinuncia a questo obiettivo di importanza strategica per Firenze (città mondiale per vocazione naturale), ha rilanciato uno schizofrenico dibattito sulle "sovranità locali" dei Comuni dell'hinterland fiorentino, innescando un processo infinito di rivendicazioni frustrate da parte dei Comuni definiti "satelliti" o " sudditi" di Firenze, di vendette meditate a lungo nel tempo impedendo la realizzazione di opere o di trasformazioni urbane essenziali per tutti i cittadini dell'area metropolitana.
Così abbiamo avuto Piani dei rifiuti ingovernabili da un'unica Autorità, Piani della mobilità anarchici o sovrapposti attraverso i quali si sono costruite prima le infrastrutture e poi gli insediamenti, rovesciando una logica urbanistica che in tutta Europa trova invece pratica e concreta applicazione.
Eppure, se si ha la pazienza e la voglia di rileggere la storia recente del dibattito urbanistico all'interno dell'area metropolitana, ci si accorge che lo stesso Progetto di Parco metropolitano, oggi portato all'attenzione da vicende urbanistiche che riguardano l'area di Castello e dell'Osmannoro, era il frutto proprio dello Schema strutturale dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, che fu addirittura approvato dal consiglio Regionale con atto deliberativo e reso cogente a tutti gli effetti.
Per dare concretezza ad un'idea non vincolistica di Parco, idea assai avanzata per l'epoca di cui parliamo, la regione decise di avviare l'attuazione dello Schema Strutturale attraverso il progetto direttore del Parco metropolitano, in particolare le aree rurali comprese tra Sesto, Campi, il Parco dell'Arno e le aree agricole perturbane di Prato.
Questo spiega perché ancora oggi il Parco metropolitano costituisce parte integrante dei PRG di Sesto e Campi Bisenzio.
Tuttavia, quell'idea di parco rimase un disegno sulla carta per due ragioni: la prima perché lo Schema strutturale non venne gestito come strumento di coordinamento della pianificazione comunale, confermando l'ostilità politica dei Comuni ad accettare, ciascuno, una cessione della propria specifica sovranità in funzione di un obiettivo di interesse comune della collettività.
La seconda, di straordinaria attualità ancora oggi, perché un Piano territoriale di un Parco è uno strumento "vuoto" se non è accompagnato da un Piano di gestione economica e sociale degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal piano stesso.
I circa 700 ha di aree rurali e libere, ancora oggi disponibili per questa idea di parco metropolitano, non sono mai state percepite dalle popolazioni che vivono in centri urbani divenuti oggi assai forti, quali Sesto, Campi, Cadenzano, Prato, come un "sistema complessivo" utile ai bisogni sociali e culturali, all'esercizio di attività per lo sport e il tempo libero ( piscine pubbliche e sistemi del benessere moderno), ma anche aree agricole urbane produttive o spazi per eventi commerciali importanti ( quali fiere o spazi espositivi dell'industria vivaistica e floristica pistoiese). Nonostante che in questa area di pianura vivano circa 700.000 persone, l'ambiente rurale che costituisce una " potenziale" green belt tra le due conurbazioni di Firenze Nord Ovest e Prato-Pistoia, è stata considerata, e lo è ancora oggi, un paesaggio rurale in attesa di urbanizzazione.
Ecco, perché, dal 1990 in poi questi 700 ha sono stati progressivamente considerati come uno "spreco" per i vari progetti che si sono susseguiti e che hanno pensato, in modi diversi, di ricondurli alla stringente logica dell'urbanizzazione e della loro definitiva cementificazione.
Così che quando i progetti di ampliamento dell'Aeroporto di Peretola, della nuova Scuola Nazionale dei marescialli dei carabinieri, della nuova sede della Regione, delle nuove scuole della Provincia, del nuovo Stadio di calcio con relativa "Cittadella dello Sport" disegnata da Fuksas, si sono affacciati all'imbocco della Porta del Parco metropolitano, tutti i soggetti politico-istituzionali aventi competenza sulla pianificazione dell'area vasta, hanno unanimemente considerato il Parco metropolitano come un "lusso che Firenze non poteva permettersi" e qualcuno è andato anche oltre affermando che "l'idea di Parco era una gran cagata".
Dunque, possiamo dire che sono mancate due questioni essenziali, contenute invece in quello schema strutturale approvato dalla Regione, negli anni 90.
La prima è quella di una "visione di sviluppo" della città, assumendo la piena consapevolezza che i processi di globalizzazione obbligavano anche Firenze a cambiare il proprio "ordine urbano"secondo nuovi paradigmi pianificatori , quali la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento dell'impronta ecologica, la trasformazione del sistema di mobilità individuale e collettivo in modo da rafforzare la policentricità del modello di città metropolitana.
La seconda è stata la deliberata scelta di non progettare, secondo uno Schema direttore coordinato e condiviso da parte delle popolazioni, la "nuova rete" di nuclei urbani e di sistemi insediativi essenziali per la nascita " non ideologica" della città metropolitana, dotata di poteri effettivi di coordinamento nella pianificazione territoriale, nella programmazione energetica, nella pianificazione d'uso delle risorse idriche, nella programmazione delle nuove aree produttive secondo un criterio distrettuale allargato all'area vasta, nella pianificazione di un sistema di connettività ecologica e paesaggistica che aiutasse a sostenere lo straordinario patrimonio storico-artistico e monumentale contenuto nella Piana e lungo l'emiciclo delle Colline fiorentine.
(2-continua)
