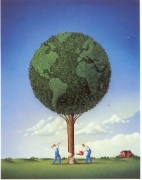
[25/03/2010] News
Green economy, energia e cambiamenti climatici (1)
LIVORNO. Da molto tempo si parla di "green economy"; alla base della sua attualità possiamo mettere i "tre 20%" che l'Unione Europea fissò nel 2007 come obiettivo al 2020 per tutti i Paesi Ue - 20% di riduzione dell'anidride carbonica, 20% di riduzione dei consumi tramite l'uso efficiente dell'energia (il "risparmio energetico"), 20% di fonti rinnovabili per coprire la totalità dei consumi energetici - che hanno costituito il lancio per una sfida globale sull'innovazione tecnologica e sull'economia, con un impatto sociale e culturale così rilevante da far parlare di "rivoluzione energetica".
La sfida è stata raccolta e i tre 20% e il 2020 sono divenuti nel corso del tempo il punto di riferimento per tutti: da Obama che, con difficoltà analoghe a quelle che ha avuto per la legge sulla salute pubblica, cerca di varare il suo provvedimento per il taglio della CO2 - 160 miliardi di dollari e oltre due milioni di posti di lavoro -, al premier giapponese Hatoyama, che ha presentato pochi mesi fa a New York il suo green plan in accordo con gli obiettivi europei, alla stessa Cina che è impegnata a coprire il 15% dei suoi consumi d'energia con fonti rinnovabili.
La conferenza delle parti, COP-15, che si è tenuta il dicembre scorso a Copenhagen, anche se non si è conclusa con la fissazione di cifre e di obiettivi precisi, ha evidenziato che ormai 192 governi di tutto il mondo sono impegnati su questo percorso e su una trattativa. Una trattativa difficilissima perché richiede, soprattutto ai paesi industrializzati, un cambiamento profondo del modello di sviluppo produttivo ed economico, con rilevanti ricadute sugli stili di vita. La realizzazione di quegli obiettivi comporta infatti di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di circa il 40%, in soltanto dieci anni!
Un'impresa titanica, se pensiamo che ancor oggi il sistema energetico mondiale dipende da petrolio, carbone e gas per l'80% del suo fabbisogno, e alla colossale inerzia - interessi economici e finanziari, decine di milioni di posti di lavoro ecc. - di questi grandi sistemi energetici.
Un altro fondamentale aspetto della rivoluzione energetica è che già il suo primo passo, al 2020, configura una transizione dall'attuale modello di sviluppo, caratterizzato ancora da un'alta densità d'energia, verso un modello di fonti energetiche decentrate, diffuse sul territorio, più direttamente accessibili e controllabili da parte dei cittadini: insomma, senza indulgere a miti, un modello più democratico. Anche perché questa transizione richiede un impegno colossale da parte di tutti i livelli di governo - da quello globale a quelli nazionali fino ai governi delle città - ma difficilmente potrà essere realizzata senza un protagonismo di base, una partecipazione attiva dei cittadini.
Ma - obietterà qualcuno - questa rivoluzione energetica è un fatto secondario nel quale il capitalismo si può permettere di esibire il volto umano. Il vero volto resta quello grifagno e irresponsabile della crisi economica scatenata da una finanza omicida. Il capitalismo è certamente oggetto di una profonda trasformazione, che negli ultimi trent'anni sta portando le società più avanzate - India e Cina incluse - dall'era dell'industrialismo a quella dell'informazionalismo, come è stata definita da molti studiosi questa nostra epoca: il passaggio dalla società delle macchine e delle fabbriche a quella dell'informatica e del web. E sarebbe sbagliato farsi sviare, non riconoscere questo trend, a causa della gravità della crisi economica.
La rivoluzione energetica, la green economy è molto omogenea e incrociata a questo indirizzo. Non fu la dematerializzazione delle produzioni (rapporto Saint Geours delle Cee, 1979) a intuire e anticipare, proprio dall'angolo visuale dell'energia, quello che si sta sempre più affermando come l'orizzonte di questo secolo? Perché, proprio guardando alle cifre dei consumi energetici e al modificarsi della richiesta nei settori di impiego era legittimo attendersi nei Paesi industrializzati un alleggerimento delle produzioni, un progressivo affermarsi delle reti rispetto ai blocchi, un'innovazione tecnologica che a macchine, motori e sferraglianti processi industriali avrebbe teso a sostituire bit.
Certo, la massività del modello di sviluppo da superare è tale che, anche se riduce la velocità, ci fa correre il rischio che il pianeta e le sue risorse materiali vadano a sbattere, spoliati ed erosi prima che la trasformazione in corso faccia sentire i suoi effetti. Proprio per questo fu proposto da tempo, ormai un trentennio, un percorso verso l'economia dello "stato stazionario": un trentennio di grandi battaglie ambientaliste in tutto il mondo - un segno che ha contraddistinto anche il movimento no global - che in nome dell'ambiente, della salute e dell'uomo sono riuscite se non altro a imprimere al mercato svolte molto significative verso la sostenibilità.
