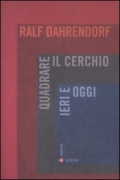
[10/08/2009] News
Quadrare il cerchio ieri e oggi
LIVORNO. "Il compito che incombe sul primo mondo nel decennio prossimo venturo è quello di far quadrare il cerchio fra creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica. La quadratura del cerchio è impossibile; ma ci si può forse avvicinare, e un progetto realistico di promozione del benessere sociale probabilmente non può avere obiettivi più ambiziosi". Questo era l'ammonimento che il sociologo Ralf Dahrendorf dava alle stampe per Laterza nel 1995, con una premessa non troppo tranquillizzante: "I paesi dell'Ocse, per dirla in modo molto diretto e sbrigativo, hanno raggiunto un livello di sviluppo in cui le opportunità economiche dei loro cittadini mettono capo a scelte drammatiche. Per restare competitivi in un mercato mondiale in crescita devono prendere misure destinate a danneggiare irreparabilmente la coesione delle rispettive società civili. Se sono impreparati a prendere queste misure, devono ricorrere a restrizioni delle libertà civili e della partecipazione politica che configurano addirittura un nuovo autoritarismo. O almeno questo sembra essere il dilemma". Per evitare questo rischio, appunto, Dahrendorf indicava come orizzonte da perseguire "nel decennio prossimo venturo" la quadratura del cerchio fra creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica.
A distanza di quasi quindici anni e con il "decennio prossimo venturo" che in realtà per noi è già trascorso, Laterza offre una rilettura di quel saggio (da cui scaturì anche un'interessante dibattito su Repubblica con l'allora direttore Eugenio Scalfari e lo stesso dahrendorf), da parte di 10 ‘pensatori' del nostro tempo, che in modo diverso e anche con acume certamente diversi, ‘fanno le scarpe' a un saggio che all'epoca fece molto scalpore.
La critica più coraggiosa e forse anche più acuta è quella proposta dall'economista, politico ed intellettuale (nonché ex deputato dell'Ulivo) Michele Salvati, che evidenzia gli errori del ragionamento del sociologo liberale dimostrati dagli accadimenti di questi ultimi anni, annotando che "se Dahrendorf dovesse riscrivere oggi il suo saggio (...) la stessa quadratura del cerchio in presenza di un semplice rallentamento dello sviluppo gli sembrerebbe un problema minore, e concentrerebbe la sua analisi e le sue preoccupazioni su minacce ben più gravi che allora appena si intravedevano ma ora sono in piena vista(...). Il problema teorico-politico cui indirizzare l'analisi sarebbe una versione assai più aspra dei problemi trattati nel saggio, ovvero: può una democrazia liberale sopravvivere come forma di governo in cui le risorse diventano veramente scarse e da tensioni e disagi si passa a conflitti distributivi aperti?".
Dei dieci intellettuali coinvolti insomma, Salvati è probabilmente quello che arriva a mettere a fuoco più da vicino che probabilmente per far quadrare il cerchio (o per tendere a), è necessario impostare il ragionamento non su sole 3 gambe come aveva fatto Dahrendorf, bensì su 4, aggiungendo a creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica, anche lo ‘sviluppo sostenibile':
"Erano già visibili 14 anni fa - scrive Salvati - ma oggi è proprio impossibile non concentrare le nostre preoccupazioni su alcune ‘influenze negative' (della globalizzazione, ndr). Soprattutto quella relativa alle conseguenze sull'ambiente e sulle risorse disponibili di uno sviluppo economico che oggi coinvolge miliardi di persone, un numero 4 volte maggiore a quello dell'età dell'oro (post bellica, ndr). Già in quella fase la crescita economica aveva prodotto gravi danni all'ambiente e reso scarse le risorse (energetiche, idriche, agricole, minerarie). Ciò che avverrà se lo sviluppo ormai mondiale procederà a questi ritmi, se India, Cina, Brasile e Sud est asiatico vorranno avvicinarsi ai livelli di reddito (e di consumo) pro capite che il nostro angolo di mondo ha raggiunto, è difficilmente immaginabile ma probabilmente disastroso per lo stesso equilibrio ecologico del pianeta".
Seppur in modo piuttosto grezzo, Salvati individua nell'errata gestione delle risorse il cuore del problema attuale, intuendo (ma non esplicitandola) la necessità di riscoprire il vero ruolo dell'economia, ovvero lo strumento attraverso cui governare le risorse disponibili e la polis (garantendo così quella promozione del benessere che Dahrendorf individuava come obiettivo ultimo da perseguire).
Persino un manager come Corrado Passera focalizza (e condivide) la dura critica di Dahrendorf all'economicismo, inteso come "l'egemonia della prospettiva economica sulla politica, sulle policiesm sull'etica e sui comportamenti sociali". Pur intravedendo come sbocco finale "la pluariltà della tradizione liberale europea", Corrado Passera riconosce che la politica, deve tornare in senso pieno se stessa, portatrice di un suo progetto articolato per la polis, che include l'economia ma non si risolve nella sola economia". Politica che quindi deve avere "un suo progetto autonomo, capace di decidere, cioè di orientare i proccessi sociali e le scelte collettive ora troppo spesso abbandonate a sé stesse".
Mentre è un cattolico come Lorenzo Ornaghi, rettore dell'Università Cattolica di Milano, a individuare nella malattia che ha impedito alla società attuale di seguire le sei "modeste raccomandazioni" che chiudevano il saggio di Dahrendorf del 1995, proprio "l'insensibilità nei confronti del futuro": "Più che dal timore del domani, le società del primo Mondo insieme con ogni pars principians che le rappresenta e governa, sembrano indifferenti a tutto ciò che del futuro - poco importa con quale grado di probabilità o verosimiglianza - non sia una replica in positivo del presente"
In realtà per il resto, in questi 10 commenti a Dahrendorf, la "visione del mondo" è ben poco organica, olistica ed ecologica: vale la pena forse di citare Federico Rampini, acuto conoscitore dell'oriente di oggi, che punta l'indice contro "la vulgata della globalizzazione, presente per esempio nei libri di Giulio Tremonti: l'idea che noi affrontiamo la concorrenza di Cina, India e altri ‘con le mani legate dietro' perché abbiamo troppe regole da rispettare, con i diritti dei lavoratori e le leggi a tutela dell'ambeinte citate come fardello. Questa visione è particolarmente miope nel caso dell'ambiente - fa notare Rampini - in realtà proprio quei paesi che hanno regole ancora più severe delle nostre - e le rispettano più di noi, vedi il caso Germania - sono stati stimolati a inventare soluzioni avanzate che riescono a vendere alle nazioni emergenti". Insomma: Il business delle tecnologie verdi nasce laddove l'ingegno imprenditoriale è pungolato da legislazioni severe. E cos'è questo se non un riorientamento verso un'economia ecologica?
Infine concludiamo citando una ‘sensazione' di Innocenzo Cipolletta, che nel suo intervento sostiene che "non esiste una contabilità certa per misurare benessere, coesione e libertà nel mondo, ma la sensazione è che questi tre elementi non siano complessivamente regrediti". Invece di affidarsi alle sensazioni, non sarebbe più utile impegnarsi per produrre e avviare davvero un sistema di contabilità ambientale e sociale (insomma ‘misurare benessere', come dice lui), in grado di fornire dati davvero seri a servizio della governance?
