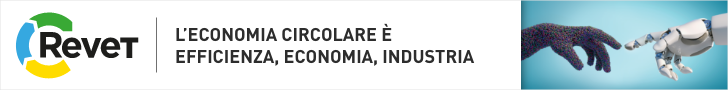Alla deriva. Il destino dei parchi nazionali

Il titolo è preso a prestito da un editoriale di Mario Tozzi del 30 settembre 2011, che aggiungeva per i Parchi nazionali “esempio di quanto l’ambiente sia difeso in questo Paese solo a parole e certo non nei fatti”, allorquando la “spending review” tagliava organici, onorari e fondi, tanto da ridurli all’insofferenza gestionale sui rilevanti compiti istituzionali dettati dalla Costituzione italiana (art. 9 e 32), che spesso la Corte dei conti ha segnalato al Parlamento come “impossibilità di gestione per la scarsità di personale e competenze adeguate”.
In questi ultimi mesi, non è solo l’effetto disastroso di quelle scelte ma l’aumento degli scontri istituzionali e le prese di posizione sulla ormai inattuale governance dei Parchi, a far intravvedere una ulteriore e definitiva deriva, tanto che, ad interpretare il rispetto delle regole e la più rilevante competenza statale, ci pensano le aule di tribunale con disposizioni talvolta incomprensibili.
A farne le spese sono sempre i cittadini che lì vivono, quale vero avamposto della tutela di questi Patrimoni unici in Europa (l’Italia è “ancora oggi” il Paese con maggiore biodiversità d’Europa), in molti casi dichiarati dall’Unesco come Patrimoni dell’intera umanità.
Di fatto, pur con le ormai note “criticità”, a testa bassa i parchi hanno rappresentato negli ultimi anni una delle poche voci in attivo del bilancio turistico e di fruizione del Paese, dando una spinta significativa all’economia del ben-essere, creato nuova occupazione soprattutto nel settore del turismo responsabile (in grande crescita dopo il Covid-19), e reso il nostro Paese migliore, più bello e ricco di paesaggi e specie faunistiche che avrebbero rischiato di scomparire.
Alla deriva, rispetto ai ritardi con i quali sono da affrontate in maniera strutturale le necessarie modifiche alla legge la n.394/91, da adeguare innanzitutto sul modello di governance, superando la separatezza tra i diversi regimi di tutela (statale, regionale) ripristinando un luogo di dialogo e leale collaborazione tra Stato e Regioni (es. Piano triennale art.4, programmi e politiche di sistema art.1 bis, ruolo di soggetti intermedi della programmazione art.7), dando centralità alle responsabilità costituzionale dello Stato, rafforzata dalle recenti modifiche negli articoli 9 e 41 che vedono l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, in un’ottica di giustizia anche verso le future generazioni, “una bussola molto importante nel percorso verso la transizione ecologica” determinando,“una maggiore integrazione tra dimensione ecologica e dimensione economica e sociale”.
In questo quadro, appare determinante ed urgente modificare l’assetto istituzionale per la tutela di questo Patrimonio, andando oltre le norme sul “parastato” che ancora li regolano e avviare una profonda innovazione che integri le aree ad alto valore naturalistico di livello nazionale e regionale con un modello gestionale che operi in maniera strutturale con le competenze e le funzioni della “terza missione” delle università italiane nei campi di interesse. Altro elemento decisivo è la semplificazione, superando i livelli di pianificazione e la ormai acquisita estrema burocrazia che portano con se questi strumenti (limitandosi al quadro di conoscenza approfondito delle vocazioni e delle reti ecologiche), per operare con specifici piani di azione e nuovi strumenti gestionali (es. connettività e infrastrutture verdi, piani integrati per la tutela della biodiversità, piani di adattamento al clima, mitigazione e prevenzione dei rischi, presidi ambientali permanenti, operatori per l’ecologia), integrando la tutela della biodiversità introdotta dalle direttive comunitarie con nuove norme per questi patrimoni (es. Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia - Risoluzione C. 356/06 e infrastrutture verdi - SB-UE 2030) per affrontare con rinnovato vigore le tante infrazioni comunitarie in materia, che pesano notevolmente sul bilancio dello Stato.
Per rilanciare un sistema in grande difficoltà, pur rappresentando un pezzo fondamentale nostri primati in Europa, anche in termini economici, di ben-essere e di crescita sociale e culturale, è necessario integrare i nuovi principi e valori della Costituzione italiana con i nuovi indirizzi della Commissione europea che, per la prima volta, nella Strategia della biodiversità 2030 si occupa in maniera determinante delle “connettività naturali” come “infrastrutture verdi”, con un nuovo modello integrato con la gestione dei siti natura 2000, attraverso i Paf 2021-2027 (Priority action framework) già approvati da tutte le regioni italiane, per attivare quei “laboratori territoriali di innovazione e ricerca” a supporto dell'agricoltura 4.0 (farm to fork strategy), frenare il consumo di suolo e il suo degrado e produrre beni e prodotti riducendo le emissioni in atmosfera e il consumo di risorse naturali, unica via per contenere i cambiamenti climatici, con apposite disposizioni ministeriali con lo strumento dei “Programmi nazionali e politiche di sistema”, previsti dall’art. 1bis della legge 394/91.
Di fatto molti di questi approcci e disposizioni per “fare sistema nelle aree protette”[1] sono contenuti nel testo consolidato della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, che prevede di proseguire “il finanziamento delle Zone economiche ambientali (ZEA), coincidenti con Parchi nazionali”, da ampliare ai Parchi regionali in un modello centralizzato (per raggiungere le quote 30+30 della Seb-2030), promuovendo provvedimenti normativi che prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per le attività imprenditoriali ecosostenibili operanti nelle medesime aree (laboratori per la transizione ecologica).
Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di adattamento al cambiamento climatico favorendo la conservazione della biodiversità e la connettività ecologica (Sottoazione A5.1.d della Sbn) definendo con le aziende ed imprese accordi con i soggetti delegati alla gestione delle aree esiti natura 2000 per promuovere una gestione sostenibile in linea con i principi della Business for biodiversity della Tassonomia degli investimenti sostenibili dell’Ue, fornendo visibilità, sostegno formativo ed economico per la valorizzazione delle loro attività e produzioni a fronte del rispetto delle norme ambientali, incluse in particolare le misure delle Linee guida del Pan (misure n. 13 e 16 del Dm 10/3/2015) e delle misure di conservazione e dei Piani di azione delle infrastrutture verdi.
Insomma per evitare questa, “infinita deriva dei parchi nazionali” e dare una svolta al “sistema delle infrastrutture verdi in Italia”, è necessaria un’azione coordinata (tra più ministeri) e di rilancio delle politiche per avviare il percorso verso “un’ecologia integrale” e di quella transizione indicata dall’Europa, mai affrontata se non in termini di “emergenze” energetica, idrogeologica, climatica, industriale, tutte funzionali e indotte dalle fragilità del Paese, ma anche da un modello di economia in declino nella quale continuiamo a “crogiolarci” senza intravvedere la via, che pure è sotto i nostri occhi.
[1]Vedi editoriale RETICULA n.30 di ISPRA