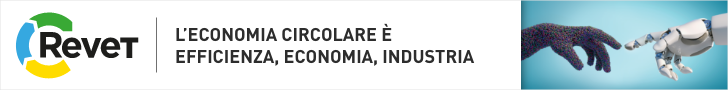Il costo della guerra per gli animali

Nel 1977, due anni dopo che il Mozambico aveva ottenuto l’indipendenza dal Portogallo dopo una lunga guerra di liberazione, il Frelimo al potere, che aveva guidato la guerriglia marxista.leninista, si scontrò con la Renamo, un movimento armato di destra filo-portoghese, e il Paese sprofondò in una brutale guerra civile durata 15 anni (ma che ha visto anche fiammate successive) e che ha causato circa un milione di morti e milioni di sfollati interni e profughi negli altri Paesi confinanti.Ma gli esseri umani non sono stati le uniche vittime di questo conflitto.
Quando nel 2012 Joshua Daskin, allora studente del primo anno di ecologia e biologia evolutiva alla Princeton University, arrivò nel Parque Nacional da Gorongosa in Mozambico, i suoi grandi animali stavano ritornando in territori in cui erano stati praticamente eliminati: Gorongosa, che fino agli anni '70 era una tra le aree dell’Africa con la fauna selvatica più spettacolare, era stata devastata prima dalla guerra di liberazione anticoloniale e poi dalla spaventosa guerra civile. Due conflitti che avevano sterminato più del 90% della fauna selvatica del parco.
Il passato violento dell’area protetta incuriosì Daskin e Robert Pringle, un professore di ecologia e biologia evolutiva della Priceton che lo aveva accompagnato in Mozambico, e si chiesero se declini simili della fauna selvatica si fossero verificati in tutta l'Africa durante i molti conflitti che hanno sconvolto il Continente nel XX secolo e, se questo fosse accaduto, quanto fossero stati gravi gli impatti sulla fauna e se in genere gli animali conservassero la capacità di recupero dimostrata da quelli di Gorongosa, oppure se la guerra fosse un tipo di pressione umana insopportabile per la maggior parte degli animali.
Da quelle domande ne è venuto fuori lo studio “Warfare and wildlife declines in Africa’s protected areas”, sostenuto dalla National science foundation e dal Princeton environmental institute (Pei) e appena pubblicato su Nature da Daskin e Pringle. Infatti, dopo anni di studio dei conflitti nelle aree protette africane, i due ricercatori hanno constatato che «La guerra è stata un fattore costante nel decennale declino dei grandi mammiferi in Africa. A popolazioni che erano stabili nelle zone pacifiche è bastato solo di un leggero aumento della frequenza dei conflitti per iniziare una spirale discendente». Però Daskin e Pringle aggiungono che «se le popolazioni selvatiche diminuiscono nelle aree di conflitto, raramente sono crollate al punto da rendere impossibile il recupero».
I due biologi hanno scoperto che tra il 1946 e il 2010 - il periodo che ha visto il rovesciamento del dominio coloniale europeo e poi, in molti Paesi, violente lotte post-coloniali e neo-coloniali per il potere e le risorse - guerre e guerriglie hanno interessato più del 70% delle aree protette dell'Africa facendo strage di elefanti, ippopotami, giraffe e altri grandi mammiferi, che soldati, guerriglieri e i cittadini affamati cacciavano per la carne e per prodotti commerciabili come l'avorio con i quali finanziare le guerre.
Daskin, che ora è Donnelley postdoctoral fellow alla Yale University, dice che, nonostante tutto questo, «I risultati [dello studio] dmostrano che anche le aree protette più gravemente colpite da un conflitto rimangono candidate promettenti per gli sforzi di conservazione e ripristino. Ci auguriamo che i nostri dati e conclusioni contribuiscano allo sforzo per dare priorità a queste aree perché ricevano attenzione e finanziamenti da parte dei loro governi e delle ONG internazionali. Stiamo presentando le prove che, nonostante il declino dei mammiferi nelle zone di guerra,le loro popolazioni spesso non si estinguono. Con le politiche e le risorse giuste, dovrebbe essere spesso possibile invertire il declino e ripristinare degli ecosistemi funzionali, anche in aree storicamente soggette a conflitti».
Secondo Pringle, «Questo studio era necessario per stabilire un'aspettativa scientifica generale sul modo in cui i conflitti colpiscono solitamente le popolazioni di animali selvatici. Per noi, prima non era chiaro se un conflitto avrebbe avuto effetti negativi sulle popolazioni selvatiche. Diversi studi, su luoghi diversi in tempi diversi, hanno riscontrato effetti positivi e negativi di un conflitto sulla biodiversità, ma l'effetto netto complessivo non era mai stato misurato. Ad esempio, ricerche precedenti hanno dimostrato che le popolazioni animali sono aumentate in regioni contese come la Zona demilitarizzata coreana (Dmz) e nello Zimbabwe rurale durante la guerra Bush del 1964-1979».
Ma Daskin e Pringle hanno rilevato che, «Con poche eccezioni, frequentemente i conflitti hanno provocato una tendenza al calo tra le popolazioni di grandi animali. Nessun altro fattore valutato ha mostrato lo stesso effetto coerente. Non vi è stato alcun effetto statisticamente rilevabile sulle traiettorie della fauna selvatica provocate da estrazione mineraria, sviluppo urbano, dacorruzione, siccità, o anche dall'intensità del conflitto, misurata attraverso il numero di vittime umane in battaglie».
Daskin sottolinea che «Questo ci ha permesso di formulare alcune ipotesi plausibili su quali potrebbero essere i meccanismi sottostanti. La maggior parte degli effetti di un conflitto sulle popolazioni di fauna selvatica sembrano essere dovuti agli effetti socioeconomici a catena che degradano la capacità istituzionale di salvaguardare la biodiversità, o alla capacità collettiva della società di stabilire delle priorità e di pagarle».
Hugh Possingham, responsabile scientifico di Nature Conservancy, che non ha partecipato allo studio ma si occupa e scrive da anni di questi temi, è d’accordo sul fatto che «Alla fine le strutture sociali determinano il destino degli animali e delle aree protette. La scoperta più sorprendente è la forza della relazione tra la presenza di conflitti e la diminuzione dei grandi mammiferi. Si potrebbe immaginare che l'entità o la portata del conflitto sai il driver, ma, di per sé, la semplice presenza di un conflitto sembra essere un forte predittore. Questo è insolito e utile. Suggerisce che qualsiasi tipo di conflitto, anche se di basso livello, deve essere evitato e che tali conflitti possono essere indicativi di problemi sociali e istituzionali più ampi che sono il principale motore del declino dei mammiferi. In conclusione: per fermare le minacce come la caccia alla selvaggina, la governance deve essere davvero forte».
Daskin e Pringle hanno scoperto che non solo il 71% delle aree protette dell'Africa ha subito uno o più conflitti dal 1946 al 2010, ma che in un quarto di queste aree le guerre sono durate in media 9 anni o anche di più. Alcune grandi nazioni africane - tra cui Ciad, Namibia e Sudan (prima di dividersi in Sudan e Sud Sudan nel 2011), Repubblica democratica del Congo - hanno subito guerre e guerriglie nelle loro aree protette che in media sono durate 20 o più anni.
Per realizzare lo studio e trovare stime dell'abbondanza di una specifica specie animale per almeno due anni tra il 1946 e il 2010, Daskin ha attinto da quasi 500 fonti e poi ha confrontato i dati raccolti per calcolare il cambiamento della densità di popolazione durante un dato intervallo di tempo. Quindi ha utilizzato una serie di database per identificare quanti conflitti si sono sovrapposti in ciascuna delle aree protette africane durante il periodo di tempo oggetto dello studio. Alla fine, i due ricercatori hanno esaminato le tendenze di 253 popolazioni di animali che rappresentano 36 specie, dalle antilopi agli elefanti, in 126 aree protette in 19 Paesi.
Daskin fa notare che «Nessun altro aveva fatto lo sforzo di riunire i dati sui conflitti in questa gamma di parchi e confrontarli con i dati della fauna selvatica. Questi dati erano tutti disponibili gratuitamente, ma non sempre accessibilissimi». Daskin e Pringle dicono che «Gorongosa, il parco in Mozambico che originariamente ha ispirato lo studio, esemplifica l’impatto dei risultati. Dal 1977 al 1992, i soldati governativi, le milizie antigovernative e i rifugiati hanno alternativamente combattuto o sono fuggiti attraverso il Parco. Per anni dopo la guerra, i residenti sfollati e diseredati hanno cacciato la fauna selvatica. All'inizio degli anni 2000, la popolazione di elefanti era crollata di oltre il 75%, mentre i censimenti aerei successivi hanno rilevato che i numeri di bufali, ippopotami, gnu e zebre erano ridotti a una o due cifre. Eppure nessuna di queste popolazioni animali è completamente scomparsa. Dal 2004, la fauna selvatica di Gorongosa è ritornata all'80% della sua abbondanza totale di prima della guerra. Lo staff del Parco, il governo del Mozambico e il Gorongosa Restoration Project no profit hanno collaborato con le comunità vicine per nutrire le rimanenti popolazioni animali, sopprimendo la caccia illegale e creando opportunità educative e occupazionali per gli abitanti dei villaggi all'interno del parco».
Secondo Pringle, che fa parte del consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione del Gorongosa Restoration Project, «I nostri risultati dimostrano che il caso del Gorongosa potrebbe essere generalizzato. Gorongosa è stato il più vicino possibile a spazzare via un'intera fauna senza estinguerla e lì stiamo anche vedendo che possiamo recuperare le popolazioni di animali selvatici e far ricrescere un ecosistema funzionale. Questo suggerisce che gli altri siti ad alto livello di conflitto del nostro studio possano, almeno in linea di principio, essere recuperati».
Nel loro studio, Pringle e Daskin sottolineano che «Il recupero della fauna selvatica è nelle mani della popolazione locale» e Pringle aggiunge: «Mi piacerebbe vedere le organizzazioni conservazionistiche e umanitarie collaborare nei lavori di soccorso post-conflitto. La ripresa a lungo termine dipende dalla salute e dalla speranza delle persone e gli ambienti sani catalizzano la salute e la speranza umana. E’ un positive-feedback loop».
Possingham concorda e conclude: «Quando le persone hanno un interesse personale ed economico ad avere un ecosistema florido, adottano comportamenti protettivi come la prevenzione del bracconaggio e il monitoraggio della fauna selvatica. Questa pubblicazione conferma la filosofia che è dietro questo approccio. In ogni area in cui la protezione dei mammiferi di grandi dimensioni è una preoccupazione, è necessario coinvolgere le persone nell'iniziativa di conservazione - stabilire mezzi di sussistenza alternativi, legge e ordine, educazione, anti-corruzione, ecc. – e allo stesso tempo intraprendere azioni di protezione dell'habitat e anti-bracconaggio sul terreno. Se non si affrontano fattori fondamentali come una spaccatura nella società civile, allora agire sul campo e investire nella gestione del parco potrebbe non funzionare».