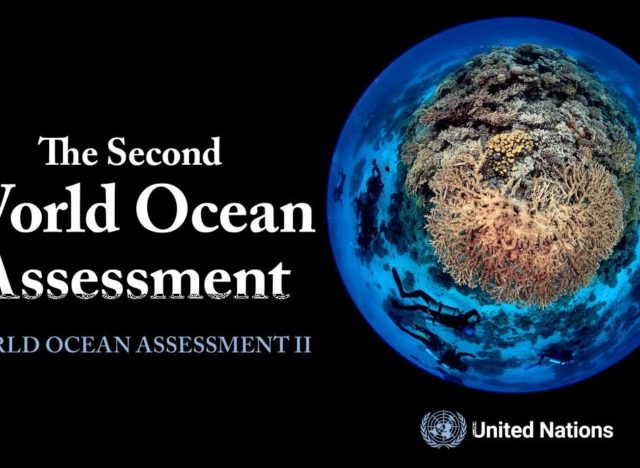Lo stato di salute del Mare. Il contributo del Cnr al secondo World ocean assessment Onu
Plancton, habitat del ghiaccio marino e impatto dei rifiuti sull’oceano
[23 Giugno 2021]
Nel 2015, il primo World Ocean Assessment (WOA I) ha messo in guardia che molte aree dell’oceano erano state gravemente degradate. La seconda valutazione degli oceani mondiali (WOA II), pubblicato ad aprile dall’Onu, è il risultato del secondo ciclo del “Regular Process for Global Reporting and Assessment of the States of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects” e copre molteplici aspetti ambientali, economici e sociali legati al mare. Uno sforzo collettivo di team interdisciplinari composti da più di 300 esperti provenienti da tutto il mondo e al quale Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha partecipato con il microbiologo Maurizio Azzaro, responsabile della sede dell’Istituto di scienze polari del Cnr di Messina, coautore in tre capitoli e già membro del Pool di esperti delle Nazioni Unite nel WOA I.
Nel capitolo (6°A; Volume I) dedicato al Plancton (fitoplancton, zooplancton, microbi e virus) Azzaro si è occupato della sua valutazione nell’oceano tra la superficie e 1.000 metri di profondità e dei suoi cambiamenti guidati dalle modificazioni climatiche che hanno maggiori probabilità di avere un impatto sui servizi ecosistemici.
Lo scienziato italiano spiega che «Il plancton marino rappresenta il gruppo di organismi più filogeneticamente diversificato sulla Terra ed è una risorsa genetica cruciale dell’Idrosfera per la sua salvaguardia e della Geosfera per l’azione che ha nel sequestro dell’anidride carbonica atmosferica oltre che nella produzione di ossigeno. Si prevede che il cambiamento climatico nel corso del ventunesimo secolo continuerà a guidare i cambiamenti nei primi 1.000 metri dell’oceano che hanno un impatto sulla diversità e la produttività degli assemblaggi planctonici su scala regionale e globale. Questi cambiamenti includeranno il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani, un decremento della salinità, un aumento della stratificazione verticale e una diminuzione dell’apporto di nutrienti inorganici nella zona eufotica, cioè illuminata, in mare aperto con relative conseguenze sulla produttività. Ai poli invece oltre all’aumento della temperatura e la diminuzione della salinità si prevede l’aumento della disponibilità di luce solare nella zona eufotica in più vaste aree oceaniche per l’arretramento del ghiaccio marino e una più ampia disponibilità di nutrienti con diretto aumento della produttività (favorendo la crescita del piccolo fitoplancton). Le reti trofiche di plancton negli oceani polari saranno le più colpite dall’acidificazione degli oceani, a causa dell’elevata solubilità della CO2 nelle acque fredde»
Nel capitolo (7k; Volume I) dedicato agli Habitat del ghiaccio marino alle alte latitudini, Azzaro ha fatto il punto sull’arretramento dell’estensione del ghiaccio che è diminuita fortemente in Artide rispetto all’Antartide e che ha fatto emergere la fragilità di questi ecosistemi polari lungo tutta la catena trofica includendo l’iconico Orso Polare Artico. Secondo il ricercatore del Cnr – Istituto di scienze polari, «La progressiva perdita di questi habitat legati al ghiaccio, soprattutto accelerata in Artide, è un’emergenza che merita una attenzione più importante nel prossimo decennio anche in termini di maggiori studi scientifici, che invece sono più concentrati sugli habitat marini. Si prevede che il ghiaccio marino artico continuerà a ritirarsi e assottigliarsi, con la prospettiva di un Artico stagionalmente libero dai ghiacci molto probabilmente già nel ventunesimo secolo, anche se la tempistica di questo evento chiave ambientale è ancora molto incerta. Il riscaldamento continuo nell’Artico dovrebbe comportare un aumento dello scioglimento del Greenland Ice Sheet favorendo la formazione di iceberg. Si prevede inoltre che il ghiaccio marino antartico, sebbene attualmente stabile, diminuirà nel corso del secolo, principalmente a causa del riscaldamento dell’oceano. Quest’ultimo dovrebbe influenzare la stabilità delle piattaforme di ghiaccio antartiche incoraggiando la fusione sub-superficiale, fino al 41–129% entro la fine del secolo, con relativo aumento del distacco di iceberg. La diminuzione del ghiaccio marino e delle piattaforme di ghiaccio continuerà ad aprire opportunità per l’espansione sia delle specie pelagiche che di quelle dei fondali marini, che beneficeranno di una più ampia e migliorata condizioni di alimentazione, mentre minaccerà la vitalità dei pesci, in particolare il merluzzo artico e tutte le popolazioni di mammiferi dipendenti dal ghiaccio marino. Molti studi suggeriscono che le alghe del ghiaccio marino diventeranno vulnerabili ai cambiamenti climatici, con ridotta biodiversità e declino demografico. D’altra parte, le fioriture di fitoplancton possono diventare più diffuse, almeno all’inizio dell’estate prima che si verifichi la limitazione dei nutrienti, sotto il ghiaccio marino più sottile e coperto di neve. Tali cambiamenti potrebbero avere impatti sull’esportazione di carbonio, con le zone di ghiaccio marino che diverrebbero stagionalmente dei serbatoi di carbonio. L’apertura dell’Artico alla navigazione, pesca e sfruttamento dei fondali e risorse più profonde avranno importanti implicazioni per gli ecosistemi di ghiaccio ad alta latitudine e per le popolazioni umane, comprese le popolazioni indigene, che sono dipendenti degli habitat di ghiaccio ad alta latitudine. Tuttavia, le rotte artiche rimarranno probabilmente di secondarie importanza ancora per alcuni decenni».
Nel Capitolo (12; Volume II) dedicato ai cambiamenti negli input e nella distribuzione dei rifiuti solidi nell’ambiente marino Azzaro si è occupato delle varie emergenze planetarie, tra le quali le microplastiche e conclude: Gli studi scientifici su questi temi stanno aumentando enormemente e mettono in evidenza, per esempio, che più di 1.400 specie sono state colpite da impatti negativi dovuti ai rifiuti marini fino all’anno 2019. Inoltre, l’impatto delle forzanti esterne sta mettendo in seria minaccia la resilienza interna del sistema Oceano e se non sarà messo sotto controllo, causerà grandi perdite in termini di risorse ecologiche ed economiche. Senza migliori politiche e mobilitazioni internazionali, l’inquinamento da plastica peggiorerà. Si stima che, se gli attuali modelli di consumo e le pratiche di gestione dei rifiuti non miglioreranno, entro il 2050 ci saranno circa 12 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica nelle discariche e nell’ambiente naturale. Le conseguenze non saranno puramente economiche e l’impatto ambientale sarà enorme. L’inquinamento da plastica può essere tuttavia usato come una porta per un’efficace educazione ambientale. La sfida è cambiare la percezione e la comprensione del problema da parte delle persone, in modo che possano vedere nella plastica l’inquinamento come vettore di educazione, consapevolezza e alfabetizzazione, nonché per trovare potenziali strategie per superare politiche economiche e barriere culturali».