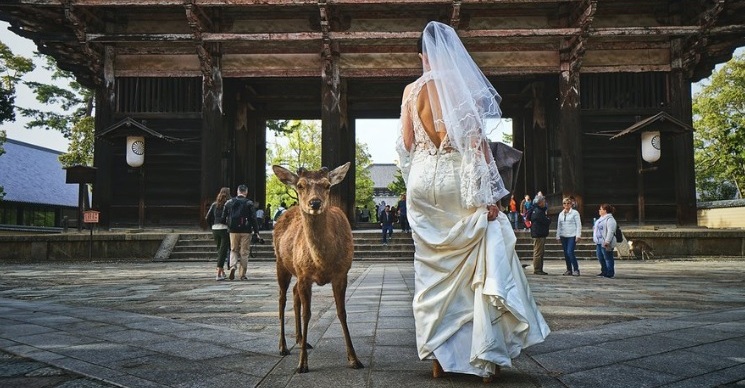Nel bene e nel male: il delicato rapporto tra esseri umani e fauna selvatica al tempo del Covid-19
Bernard Bett : «Il modo migliore per gestire le malattie zoonotiche è preservare la natura e proteggere la biodiversità»
[24 Aprile 2020]
In passato, i coronavirus che infettavano l’uomo di solito non causavano grandi epidemie, tutto è cambiato nel 2002, quando il virus SARS-CoV ha fatto il salto dall’animale all’uomo diventando quella che oggi conosciamo come SARS. Il Covi-19 che ha chiuso in casa – per chi ce l’ha – il modo è un parente del SARS-CoV-2. Bernard Bett che guida il team di ricerca sulle malattie infettive trascurate ed emergenti all’’International Livestock Research Institute che fa parte del progetto di ricerca globale Improving Human Health, con i suoi studi sulle malattie trasmissibili tra animali e umani – le zoonosi – ha contribuito molto alla realizzazione dell’UNEP Frontiers 2016 Report che ha attirato l’attenzione su un problema molto sotto valutato e che ora riguarda quasi tutti.
In questa intervista a Covid-19 Response, la rubrica informativa ospitata dall’United Nations environment programme (Unep), Bett affronta il delicato tema della relazione tra esseri umani, fauna selvatica e agenti patogeni de dice di non essere sorpreso f dalla comparsa del Covid-19: «Negli ultimi 10 anni sono state segnalate molte malattie emergenti, ma non avevamo visto nulla di simile al Covid-19, che ha colpito quasi tutti i Paesi del mondo. Quel che sorprende è la rapida diffusione di questo virus in tutto il mondo».
Ma perché le malattie zoonotiche sembrano verificarsi più frequentemente di prima? Secondo Bett «Le malattie zoonotiche stanno aumentando. Una review dei trend globali delle malattie infettive emergenti dal 1940 a oggi conferma che i loro focolai sono aumentati col passare del tempo. Circa il 60% di queste malattie sono zoonotiche e poco più del 70% delle infezioni zoonotiche sono causate da agenti patogeni che hanno origine nella fauna selvatica. Alcuni dei motivi per cui la frequenza delle malattie è in aumento è dovuto all’aumento dei contatti stretti tra fauna selvatica e uomo, all’invasioni di territorio, all’urbanizzazione e allo sviluppo socio-economico. Con l’aumentare della popolazione umana e lo sviluppo delle economie, aumenta la domanda di cibo e di altri beni. Settori come l’agricoltura si intensificano. L’uso del suolo, i cambiamenti climatici, lo sviluppo economico, la crescita della popolazione e le persone che vivono in aree densamente popolate sono tutti fattori che contribuiscono all’emergenza zoonotica, rendendo più facile la diffusione delle malattie dagli animali agli esseri umani»
Ma come avviene questo passaggio da animale a uomo e viceversa? Lo scienziato kenyano spiega ancora che «Le malattie emergenti si verificano a causa di cambiamenti nella struttura biologica di un agente patogeno, della capacità degli ospiti di resistere alle infezioni e/o della capacità dell’ambiente di tenere sotto controllo le epidemie. Un virus che potrebbe essere innocuo oggi, potrebbe evolversi in una forma molto più patogena, attraverso mutazioni genetiche o ricombinazione con altri organismi che portano tratti patogeni critici. Piccole mutazioni si verificano spesso quando i virus si moltiplicano o come meccanismo per consentire a questi virus di sopravvivere meglio nei loro ospiti. Per quanto riguarda gli esseri umani, pensiamo ai cambiamenti nelle pratiche di sostentamento, principalmente allo sviluppo socio-economico, che in genere promuove l’agricoltura intensiva nella quale molti animali vengono allevati in un ambiente piccolo e denso. Gli animali e gli uccelli che vengono spesso allevati in tali allevamenti presentano una stretta diversità genetica. Le popolazioni di ospiti geneticamente omogenee sono più suscettibili alle malattie. L’utilizzo del suolo e i cambiamenti climatici degradano la capacità di un ambiente di controllare le malattie. Queste destabilizzano le interazioni patogeno-ospite che si verificano in ambienti incontaminati, aumentando quindi le opportunità di ricadute zoonotiche. Un maggiore utilizzo delle aree protette, ad esempio per l’orticoltura, il pascolo illegale di bestiame o la caccia per la carne di animali selvatici, mette in contatto diretto esseri umani e animali domestici con ambienti potenzialmente infetti. Quando le persone degradano gli habitat della fauna selvatica o stabiliscono i propri insediamenti in alcune aree, diventano parte dell’ecosistema. Entrano a far parte del ciclo silvatico, il ciclo di trasmissione del virus che avviene tra gli animali nelle foreste. Se si mette insieme queste tre cose, si ha un ambiente ideale per le malattie zoonotiche».
L’intervistatore chiede a Bett: «Direbbe che gli umani stanno assottigliando i confini tra la vita umana e quella animale?» LO scienziato risponde facendo notare che «L’urbanizzazione influenza l’insorgenza della malattia in modi particolari. Acque reflue e sistemi di smaltimento dei rifiuti forniscono condizioni ideali per vettori, roditori, uccelli e artropodi che possono trasmettere i patogeni e farli prosperare. L’elevata densità della popolazione umana negli insediamenti periurbani è un altro fattore critico che aumenta i contatti che migliorerebbero efficacemente la trasmissione di malattie infettive».
Per quanto riguarda il ruolo svolto dai cambiamenti climatici, per Bett esiste un forte legame con la trasmissione delle malattie: «Il cambiamento climatico è guidato dall’aumento delle temperature medie globali. I suoi effetti sulla trasmissione delle malattie sono complessi. In generale, un aumento della temperatura aumenta i tassi di sviluppo di vettori e agenti patogeni fino a un certo punto (circa >40° C), dove un ulteriore aumento della temperatura ucciderebbe la maggior parte dei vettori. I cambiamenti climatici aumentano anche l’incidenza di eventi estremi, come precipitazioni elevate e le inondazioni, che hanno un impatto sostanziale sulla trasmissione delle malattie. Le inondazioni, ad esempio, aumentano l’abbondanza dei vettori, portando a un’impennata delle infezioni trasmesse dagli artropodi».
Ma come si ricostruisce il delicato equilibrio tra uomo e natura? Per il veterinario dell’International Livestock Research Institute la cura è la natura stessa: «In termini di malattie, la biodiversità è la chiave per mantenere la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. La ricerca ha dimostrato che quando si preserva la natura e quando si hanno più specie ospiti su un territorio, si riduce il rischio complessivo di trasmissione di un agente patogeno attraverso ciò che gli scienziati chiamano effetto di diluizione. Questo perché in una popolazione mista di ospiti, alcuni sarebbero ospiti “senza uscita”, che non consentono il verificarsi di un’infezione, quindi preservare la natura è un modo per mitigare la trasmissione della malattia».
Ma quali lezioni possiamo trarre dalla pandemia in corso? «In primo luogo – dice Bett – dobbiamo segnalare queste malattie non appena si verificano e creare un intervento efficace. In secondo luogo, è bene continuare ciò che stiamo facendo ora: sviluppare farmaci e vaccini che possono essere utilizzati durante le epidemie. In terzo luogo, dovremmo pensare a incentivi che consentano alle comunità di partecipare al controllo delle malattie. Il distanziamento sociale funziona bene in alcune aree, ma in altre dove le pratiche di sostentamento richiedono alle persone di spostarsi da un luogo a un altro, è difficile implementare questa misura».
Quindi cosa dovremmo fare di diverso per impedire l’insorgere delle malattie zoonotiche o mitigare i loro impatti in futuro? Bett sottolinea che «La natura si prende cura di se stessa, quindi il modo migliore per gestire le malattie zoonotiche è preservare la natura e proteggere la biodiversità. Gli interventi per le malattie infettive emergenti dovrebbero essere attuati attraverso collaborazioni multi-agenzia nell’ambito dell’One Health framework. Le malattie zoonotiche colpiscono allo stesso tempo l’uomo, il bestiame e la fauna selvatica. Gli esperti medici devono riunirsi con esperti veterinari e ambientali e gli stakeholders per trovare soluzioni a queste malattie. Anche gli scienziati sociali dovrebbero far parte di questi interventi perché dobbiamo comprendere meglio il comportamento al fine di attuare eventuali cambiamenti nelle comunità che lavorano negli hotspot delle zoonosi. Infine, dobbiamo diversificare le cose su cui ci concentriamo: guardare all’economia, guardare ai mezzi di sussistenza. Perché alla fine di tutto, quando vorremo riprenderci dalle epidemie o dalle pandemie, torneremo ai nostri mezzi di sussistenza. Sarebbe positivo per i governi pensassero ad approcci su più fronti per la gestione del Covid-19».
L’Unep conclude ricordando che «La natura è in crisi, minacciata dalla perdita di biodiversità e di habitat, dal riscaldamento globale e dall’inquinamento tossico. La mancata azione sta portando l’umanità a un fallimento. Affrontare l’attuale pandemia di coronavirus (Covid-19) e proteggersi dalle future minacce globali richiede una sana gestione dei rifiuti medici e chimici pericolosi; una gestione robusta e globale della natura e della biodiversità; e un chiaro impegno a “ricostruire meglio”, creando posti di lavoro verdi e facilitando la transizione verso economie carbon neutral. Un futuro resiliente e sostenibile per l’umanità ora dipende da come agiremo ora».